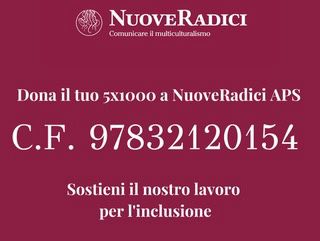Francesco Cancellato
Il muro. La fine della guerra fredda in quindici storie
(Egea, 2019)
C’è sempre un muro, quasi un’ossessione di questi tempi. Un muro lo vuole Donald Trump, per arginare i messicani pronti ad entrare negli Stati Uniti. Un muro lo hanno costruito in Israele, per tenere lontani i palestinesi nella Striscia. Anche Viktor Orbán da tempo è ossessionato dall’idea di un muro bello grande per impedire l’arrivo dei migranti in Ungheria. Ma quando si parla di un muro, anzi del Muro, ce n’è solo uno che ha fatto la Storia.
È il Muro di Berlino, costruito il 13 agosto 1961 per impedire agli abitanti della parte sovietica di andare ad Ovest e poi definitivamente crollato l’8 novembre 1989, insieme alla DDR. Un evento che ha dato l’avvio alla dissoluzione dei regimi comunisti dell’Est. Un evento che di fatto ha messo la parola fine alla Guerra Fredda.
La storia del crollo del Muro la racconta il giornalista Francesco Cancellato, vicedirettore di Fanpage e fino a poco tempo fa direttore de Linkiesta. Mescolando storie di abitanti comuni della Berlino divisa e di alcuni protagonisti della politica internazionale che hanno avuto a che fare col Muro, da Angela Merkel a Vladimir Putin, Francesco Cancellato ricostruisce una storia che nessuno può dimenticare e che molti non vorrebbero rivedere. Fabio Poletti
Per gentile concessione dell’autore e della casa editrice Egea pubblichiamo un estratto del libro Il muro di Francesco Cancellato.

Quella volta che una mongolfiera provò a fuggire verso la libertà
A volte basta nulla a definire il tuo destino. Per Winfried Freudenberg, per esempio, è bastato nascere a pochi metri da un confine e mettere troppa aria in un pallone. Era nato il 29 agosto del 1956, meno di quattro anni dopo che una cortina di ferro venne calata a dividere in due il mondo, ed era cresciuto a Lüttgenrode, nell’ultimo paese della Sassonia Anhalt, della Repubblica Democratica Tedesca e del comunismo. Di là, a poche centinaia di passi, la Bassa Sassonia, la Repubblica Federale e il capitalismo. Novantanove persone su cento avrebbero accettato passivamente questo scherzo del destino. Magari non si sarebbero nemmeno rese conto di che cosa era toccato loro in sorte per colpa di un accidente della storia.
Lui no. Costretto dalla povertà ad abbandonare gli studi da apprendista elettricista, aveva comunque deciso di frequentare “dei corsi serali dopo il lavoro, nel centro di formazione per adulti di Halberstadt, e lì era riuscito a conseguire il diploma. Non pago, si era iscritto all’università, a Ilmenau, in Turingia, dove si era laureato in ingegneria elettrotecnica. Fu lì, in un club studentesco, che Winfried conobbe Sabine, una giovane iscritta a chimica che si era innamorata di quello studente un po’ avanti con gli anni, con la barba da hipster ante litteram e il sorriso triste.
Winfried e Sabine si sposarono nella primavera del 1988. Erano giorni di disgelo, di speranze e di libertà, ma la perestrojka di Gorbaciov rendeva sempre più difficile accettare i limiti, le imposizioni e i muri della Repubblica Democratica Tedesca. Winfried e Sabine volevano viaggiare, andare ai congressi, fare ricerca, incontrare colleghi dell’Ovest. Quello che per Sabine era un bisogno, tuttavia, per Winfried era una vera e propria ossessione che superava persino l’amore per la moglie. Quel confine che guardava dalla finestra quand’era bambino si era impossessato di lui. E più voleva superarlo, più il regime di Berlino Est sembrava accanirsi contro di lui. Persino Lüttgenrode, il paese in cui era cresciuto, era diventato inaccessibile se non con uno speciale permesso. Per Honecker e il Politburo, infatti, era troppo vicino al confine per essere liberamente raggiungibile da tutti i cittadini della Germania Est. Winfried Freudenberg doveva chiedere l’autorizzazione del regime anche per tornare con Sabine nella casa in cui era cresciuto.
Due settimane prima delle nozze ottenne un permesso speciale per andare a comunicare la notizia ad alcuni parenti che vivevano ad Ovest. Generalmente questi permessi erano concessi soltanto alle persone sposate o con figli, cui era consentito varcare il confine da sole. Di fatto, la Repubblica Democratica ne teneva in ostaggio gli affetti nel caso avessero deciso di scappare. Quel giorno Winfried non provò a scappare, ma raccontò ai suoi parenti che aveva un piano per farlo: avrebbe varcato il muro che divideva Berlino a bordo di una mongolfiera, di notte.
In molti, nei ventisette anni precedenti, avevano provato a superare il Muro. I numeri raccontano di circa cinquemila tentativi riusciti e di duecento persone morte mentre azzardavano l’impresa.
Per i berlinesi dell’Est alcuni di quei temerari erano martiri o eroi. Era martire Ida Siekmann che, come Winfried, abitava a un passo dal confine: la sua casa in Bernauer Strasse era esattamente sulla linea di separazione tra il settore orientale e quello occidentale. Dalla finestra di casa sua, Ida vedeva la gente camminare sui marciapiedi di Berlino Ovest. Erano passati solo nove giorni dalla notte in cui i soldati avevano steso il primo rotolo di filo spinato tra le due metà della città. Ne mancava uno al cinquantanovesimo compleanno di Ida, il primo che non avrebbe festeggiato insieme ai suoi parenti che vivevano pochi isolati più a nord, in quello che negli anni precedenti era stato battezzato «settore francese». Ida abitava al terzo piano, e per una donna della sua età era un salto quasi impossibile. Quel giorno Berlino era assolata e terribilmente vuota. Ida gettò diverse coperte sul marciapiede, sperando avrebbero attutito l’impatto, poi saltò. Morì quasi subito. La sua tomba, una piccola lapide grigia in un angolo del cimitero municipale di Wedding, fu per anni meta di pellegrinaggi per i berlinesi dell’Est. Ida Siekmann era stata la prima vittima del Muro di Berlino.
Erano eroi, invece, Hans Strelczyk e Günter Wetzel, rispettivamente meccanico e muratore. Grazie alle loro abilità manuali, ad alcuni volumi presi in biblioteca e alle loro mogli, che cucirono tra loro pezzi di vestiti e lenzuola a formare un pallone, riuscirono nell’impresa di costruire una mongolfiera che li trasportasse dall’Est all’Ovest.
Il primo tentativo non andò a buon fine, e nemmeno il secondo, ma nessuno si accorse di ciò che stavano cercando di fare. Ci provarono una terza volta, nella notte del 16 settembre 1979, e stavolta riuscirono ad alzarsi da terra.
Volarono per due chilometri e mezzo sopra una distesa buia fino a che non furono costretti ad atterrare di nuovo, a causa del malfunzionamento della mongolfiera. Nel tornare a casa, ormai arresisi, incrociarono una guardia che indossava la divisa della Repubblica Federale. Ce l’avevano fatta. Erano arrivati a Ovest. Erano liberi.
Winfried voleva essere un eroe, come loro. Ma proprio a causa di Strelczyk e Wetzel acquistare una mongolfiera o i materiali per costruirla era diventato praticamente impossibile. Lui e Sabine, però, non si persero d’animo. Si trasferirono a Berlino Est, in un bilocale a Prenzlauer Berg, non lontano dal Muro. Winfried iniziò a lavorare alla VEB Energiekombinat, l’azienda che forniva gas ed elettricità a tutta la Repubblica Democratica Tedesca.
Lui e la moglie passavano le domeniche comprando tessuto di polietilene e fingendo che servisse per fabbricare delle tende. Lo assemblarono pazientemente, sera dopo sera, con uno speciale nastro adesivo, sino a farne un pallone di tredici metri per otto. Erano gli ultimi giorni di febbraio del 1989 quando ripiegarono con cura la tela e la chiusero con del nastro da pacchi. Ora bisognava solo aspettare la notte in cui il vento avrebbe soffiato forte, da est a ovest. La notte del 7 marzo.
I Freudenberg salirono sulla loro Trabant che era quasi mezzanotte e guidarono verso la stazione di regolazione del gas della VEB, a Pankow. Winfried aprì con le sue chiavi da dipendente e insieme raggiunsero un grande piazzale dove cominciarono a gonfiare il pallone. Fu verso l’una e mezza di notte che un giovane cameriere part-time, di ritorno a casa dopo una serata di lavoro, vide un grande pallone aerostatico sbucare dietro al tetto della stazione, a circa mezzo chilometro di distanza. Insospettito – dal 16 settembre del 1979 le mongolfiere erano sinonimo di fuga – decise di avvisare la Volkspolizei. I poliziotti arrivarono verso le due di notte, quando Winfried e Sabine stavano ancora finendo di gonfiare il pallone.
Qui la storia accelera, è questione di secondi: lui le dice che il pallone non può trasportare entrambi, che se partissero insieme faticherebbero a sollevarsi da terra. Lei lo guarda per pochi lunghissimi istanti, poi decide che non andrà con lui, che quella è la storia di Winfried, che è lui quello nato a pochi metri dal confine e che sarà lui ad andare a Ovest. I poliziotti cominciano a correre verso di loro, intimandogli di non muoversi. Lui taglia gli ormeggi e scompare nel cielo buio e gelido dell’inverno berlinese. Lei scappa.
Le cose non vanno sempre come ce le si immagina. Senza il peso di sua moglie, Winfried Freudenberg sale velocemente, più in alto di quanto avesse voluto. Sorvola il confine che divide Berlino a venti chilometri all’ora e arriva presto all’aeroporto di Tegel, dove tenta di atterrare. Manovra il bruciatore in modo da raffreddare l’aria nel pallone e fargli perdere quota, ma qualcosa va storto. Nel panico, getta a terra la zavorra sperando di attirare l’attenzione di qualcuno, ma la perdita di peso lo fa salire ancora più in alto e lo intrappola in una corrente ascensionale a più di duemila metri di altezza. Rimane lì per diverse ore, a temperature gelide, rannicchiato su un’asse di legno spessa due centimetri e lunga quaranta, sorvolando Berlino prima verso ovest, poi verso sud, poi ancora verso ovest.
All’alba un pedone lo vede galleggiare su Teufelsberg, una collina innalzata utilizzando 26 milioni di metri cubi di macerie della seconda guerra mondiale dove le forze d’occupazione statunitensi hanno costruito una stazione radar per spiare la Repubblica Democratica Tedesca, e pensa che sia un pallone meteorologico.
Sono le 7:30 del mattino quando Winfried Freudenberg, semiassiderato, allo stremo delle forze, sorvola il distretto di Berlino Ovest di Zehlendorf. Poche centinaia di metri più in là c’è Kleinmachnow e, di nuovo, la Germania Est. Per Winfried è l’ultima possibilità. Con la forza della disperazione riesce a far scendere rapidamente il pallone. Un ultimo refolo di vento, tuttavia, gli è fatale. Il pallone risale di nuovo e fa perdere l’equilibrio a Winfried, che precipita al suolo.
La mattina dell’8 marzo, camminando sulla Potsdamer Chaussee, la strada che da Zehlendorf porta verso Potsdam, qualcuno nota una strana coperta di plastica impigliata tra i rami di un albero. A terra ci sono un pezzo di legno e alcune borse. Ma è solo nel pomeriggio che un abitante della zona trova nel giardino della sua villetta a pochi metri dal confine, dalla parte giusta del confine, il cadavere di un uomo con la barba da hipster ante litteram e tutte le ossa rotte. Winfried Freudenberg è morto sul colpo. Non è riuscito a vivere a Berlino Ovest nemmeno per un solo istante.
Nel frattempo, a Prenzlauer Berg, due uomini della Volkspolizei stanno aspettando a casa Sabine, che ha abbandonato la Trabant a Pankow e vagato a piedi per tutta la notte a Berlino Est, come un fantasma. I documenti di Winfried sono volati fuori dal pallone al decollo, rivelandone identità e indirizzo. Sabine viene immediatamente arrestata, interrogata e incriminata per «tentativo di violazione del confine». La Stasi, nel frattempo, sta già mettendo sotto controllo parenti, amici e conoscenti di Winfried Freudenberg, sia a Est sia a Ovest, e cerca di bloccare la notizia della sua morte e quella dell’arresto di Sabine. Missione fallita: nel giro di poche ore tutti sanno.
Sabine, dopo un maldestro tentativo di trattativa con il governo della Germania Ovest cui fu chiesto di pagare un riscatto per la sua liberazione, venne condannata a tre anni di libertà vigilata e amnistiata sette mesi dopo. Il corpo di Winfried Freudenberg, invece, venne consegnato alla Ddr il 7 aprile del 1989 e sepolto il 24 aprile a Lüttgenrode, davanti a una folla immensa e a decine di agenti della Stasi, lì «per prevenire attività negative ostili in relazione al funerale». Non ce ne furono. Solo un rabbioso e disilluso silenzio.
Per uno scherzo del destino drammatico e beffardo Winfried Freudenberg fu l’ultima persona morta nel tentativo di superare il Muro, che cadde esattamente otto mesi e un giorno dopo il suo volo su Berlino.
Per salvarsi la vita, tuttavia, sarebbe stato sufficiente che il vento buono avesse tardato di qualche giorno. A volte, davvero, basta un nulla per cambiare tutto.
Copyright © 2019 EGEA S.p.A.