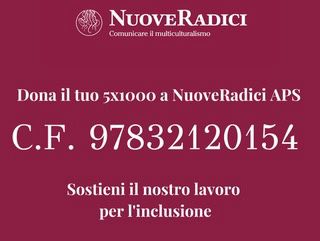Il ranocchio che si fa finalmente principe, è il coronamento a lieto fine di una fiaba. Ma, a dirla tutta, è pure il codice adottato da molti scrittori di favole che, magari senza volerlo, alzano muri e discriminazioni palesi contro i soggetti non conformi, marchiati come deformi, relegati nel ruolo di cattivi, di perdenti, quando va bene di infelici. Insomma, mai come nelle fiabe, che hanno un ruolo importante nella crescita culturale dei bambini, la diversity viene messa all’indice se non cancellata. Partendo dalla sua personale esperienza di persona con disabilità dovuta a una paralisi cerebrale, la scrittrice canadese Amanda Leduc, in questo Deforme. Fiabe, disabilità e inclusione pubblicato da Nottetempo, fa un’analisi molto accurata del linguaggio delle fiabe. Lo sguardo non è solo attraverso la lente della cultura woke, ma è una arguta riflessione sul concetto di bello e inclusivo. Il suo Deforme è stato tradotto in diversi paesi e ha costituito un punto di svolta negli studi sui personaggi disabili nelle fiabe e nella cultura di massa in generale. Leduc vive a Hamilton, Ontario. Partendo dai Fratelli Grimm a Perrault, da Andersen a Disney, le fiabe plasmano il nostro sguardo sul mondo, e ci insegnano che la felicità è riservata ai corpi perfetti. Amanda Leduc, ripercorrendo la sua esperienza di bambina, ragazza e poi donna con paralisi cerebrale, indaga queste narrazioni e mostra in Deforme come bellezza e abilità fisica siano da sempre sinonimo di virtù, mentre tutti i corpi non conformi – il gobbo di Notre Dame, i sette nani, le sorellastre di Cenerentola – vengono emarginati e sono meritevoli al massimo di una redenzione incompleta. Anche nell’universo dei supereroi Marvel, dove Hulk, Daredevil e Iron Man partono da una condizione di vulnerabilità per trasformarsi in qualcosa di superiore, si perpetua ancora oggi l’idea che la felicità e l’accettazione sociale siano possibili solo attraverso una metamorfosi che cancella l’imperfezione originaria. Questo Deforme diventa allora il manifesto che lega la lotta per i diritti delle persone disabili all’apprezzamento del patrimonio storico della fiaba. E all’immaginazione di nuove storie che spezzino la consuetudine, non nascondendo la differenza e mostrando come ogni corpo sia speciale, perché il lieto fine dipende dalle circostanze e non dai corpi. Fabio Poletti

Amanda Leduc
Deforme
Fiabe, disabilità e inclusione
traduzione di Alessandro Ceccherini
2025 Nottetempo
pagine 264 euro 17,50
Per gentile concessione dell’autrice Amanda Leduc e dell’editore Nottetempo pubblichiamo un estratto dal libro Deforme
Che sia la zucca di Cenerentola o l’improvvisa comparsa delle gambe della Sirenetta, le fiabe ruotano spesso intorno a qualcosa o qualcuno che a un certo punto del testo cambia: l’inaccessibile diviene improvvisamente manifesto grazie alla magia, alla polvere di fata e al desiderio. La fata malvagia trasforma il filatoio in uno strumento di morte nella Bella addormentata; in Cappuccetto Rosso il lupo si traveste. La stessa Cenerentola da sguattera si tramuta in principessa.
Ma non è mai la società a cambiare, non importa quante sguattere o creature metà uomo e metà animale si stiano battendo per il proprio posto a tavola. Quasi sempre sono gli stessi protagonisti che in qualche modo si trasformano – diventando più gradevoli, più belli, più adatti allo stampino della società in cui vivono. L’intervento è magico piuttosto che chirurgico, ma ci possiamo immaginare gli scrittori di queste storie argomentare in favore del modello medico: l’intervento salvavita, dove “vita” sta per reputazione e stima sociale. Il bambino che si opera per risolvere il problema di un piede equino è lo stesso a cui, in una fiaba, andrebbe a far visita una fata madrina o una strega cattiva, che gli porterebbe in dono un fisico abile offerto in modo assolutamente irresistibile.
Nelle fiabe la trasformazione dell’individuo si affida a fate e magia – o agli dei – perché è chiaro che la società non può migliorare (e infatti non accade). Di nuovo, se visto nel contesto storico in cui tali storie sono state elaborate, ciò ha quantomeno un po’ di senso: come fai a trasformare il mondo se sei un contadino con un figlio disabile, con poco o nessun potere per cambiare il luogo e la società in cui vivi? Eppure nelle storie il potere della magia ha anche, stranamente, l’effetto opposto: invece di infondere nel lettore una visione del mondo in cui il cambiamento è possibile e le cose possono prendere una piega positiva per il reietto, nelle fiabe la predominanza della magia serve a rinforzare le strutture di classe e quelle sociali esistenti, come del resto le idee tradizionali su cosa significhi avere un corpo funzionante nel mondo. Probabilmente è questo il motivo per cui c’è sempre un prezzo che il protagonista deve pagare per la magia che gli garantisce la trasformazione. Non puoi semplicemente spostarti da un luogo all’altro, la società non lo permette. E così il protagonista deve dimostrare il proprio valore, attraverso buone azioni e un comportamento gentile, come nel caso di Cenerentola, oppure, come per la Sirenetta, tramite sacrifici e prove da superare.
Se fallisce, forse può trovare una fata, oppure, come in molte fiabe dei Fratelli Grimm, può rafforzare la propria fede in Dio. “Pur sostenendo un ideale di salute e abilità fisica”, dice Ann Schmiesing, “le fiabe [dei Fratelli Grimm] suggeriscono di frequente che questo ideale è inarrivabile, quantomeno senza l’intervento divino”.
Camminare, vedere, ascoltare, toccare. I doni valgono gli sforzi, a prescindere dal prezzo che deve essere pagato.
Ho quattro anni, quasi cinque, quando lascio l’ospedale per la prima volta dopo l’operazione chirurgica in cui mi hanno aperto la testa e tagliato via pezzi della cisti. Sono ansiosa di tornare a casa. Mentre ero in ospedale con mia madre abbiamo letto tutti i libri della Casa nella prateria, alcuni due volte. (Sulle rive del Plum Creek è il mio preferito. Mi piace l’idea di Mary e Laura Ingalls che vivono in una casa sotterranea e corrono sul prato che cresce sul loro tetto.)
Un giorno, verso la fine delle tre settimane di degenza, torno nella mia stanza con l’infermiera e trovo mia madre e mia nonna in piedi accanto al dottor Humphreys.
“Abbiamo tre vestiti per te,” dice il dottore. Sorride. Mi piace tanto il suo sorriso. “Ma puoi indossarne solo uno! Quindi devi scegliere quale vuoi indossare”.
È un abito da festa – lo so anche se ho quattro anni. Stiamo festeggiando perché presto non starò più in ospedale. Presto non avrò più i bendaggi. Presto l’infermiera Margaret non dovrà più lavarmi la testa e aiutarmi a fare il bagno.
Non ricordo gli altri vestiti, ma quello che scelgo è verde chiaro. Ha le maniche corte e due file di nastro rosa sul davanti. La gonna sbuffa quando piroetto, anche se non posso piroettare velocemente a causa dei bendaggi.
Lo adoro. Mi fa sentire una principessa.
Nel modello sociale della disabilità, il “ritorno” dalla ricerca implica un riconoscimento della diversità del corpo e di come esso si inserisca, diversamente, nel mondo – e a partire da qui, un riconoscimento di come la società si debba adattare a sua volta per accoglierlo. “Gli ambienti disabilitanti”, scrive Siebers, “producono la disabilità dei corpi e necessitano di interventi a livello di giustizia sociale”. Il modello sociale si è sviluppato negli anni Sessanta come risposta delle persone disabili alla natura
patriarcale e all’infantilizzazione inerenti al modello medico. La trascrizione di un incontro del 1975 tra la uk Disability Al- liance e la Union of the Physically Impaired Against Segregation sottolinea questo punto: “Secondo noi è la società che rende disabili le persone fisicamente compromesse. La disabilità è una condizione che si sovrappone alle nostre compromissioni, generata dalle modalità con cui veniamo ingiustamente isolati ed emarginati dalla piena partecipazione sociale”. (“Fisica- mente compromesso” è un’espressione datata; veniva usata al tempo della citazione, ma oggi è generalmente considerata non accettabile se riferita alla comunità disabile.) Il modello sociale della disabilità, come termine specifico, viene coniato nel Regno Unito, nel 1983, dall’accademico disabile Mike Oliver.
Nel modello sociale si pone enfasi sulla creazione di spazi per le sedie a rotelle che possono ospitare un corpo incapace di camminare, in opposizione al bisogno di camminare a ogni costo; viene sempre più riconosciuta la necessità di cose come l’interprete del linguaggio dei segni e spazi scent-free agli eventi pubblici; c’è, come ho accennato, la consapevolezza che gli eventi e gli spazi pubblici che non offrono entrate o bagni accessibili non tengono conto delle varie necessità della popolazione. C’è, soprattutto, la spinta affinché le persone disabili vengano coinvolte in tutti gli aspetti decisionali che riguardano la loro partecipazione alla società – e il riconoscimento che la società ha una responsabilità verso tutti i cittadini, e dovrebbe soddisfare al meglio i bisogni che variano in base ai corpi. Niente che riguardi noi, senza di noi – un motto che fin dagli anni Novanta è stato as- sociato al movimento per la giustizia per la disabilità – racchiude molto dell’ethos che sostiene il modello sociale.
Titolo originale: Disfigured: On Fairy Tales, Disability, and Making Space
© Amanda Leduc 2020
© 2025 Nottetempo srl